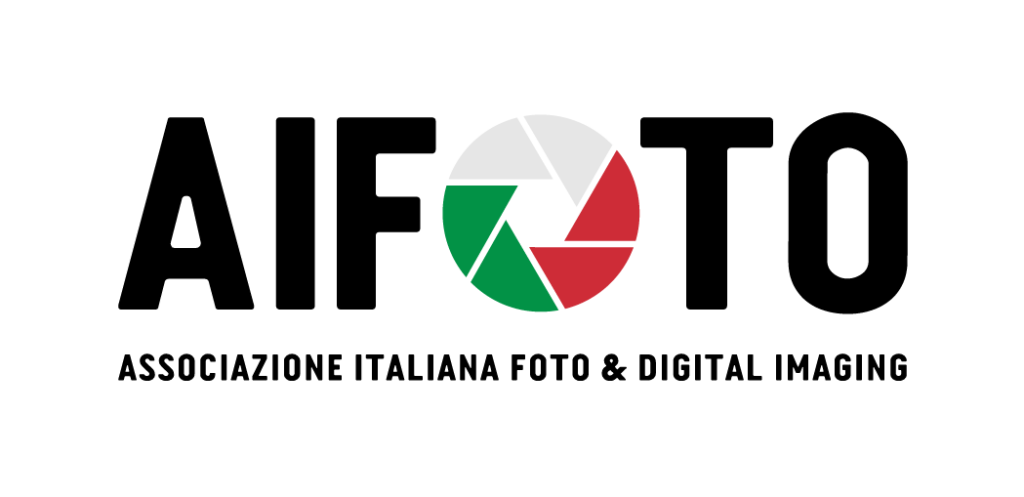“Per l’eleganza che caratterizza le sue fotografie, per i suoi ritratti che considera atti di seduzione, per uno stile che non disdegna le piccole imperfezioni. Ma anche per la passione con cui si impegna da Presidente dell’A.F.I.P. a divulgare la fotografia in tutte le sue declinazioni”, avevamo scritto nelle motivazioni del Premio AIF che avevamo consegnato nel 2019 a Giovanni Gastel in occasione della conferenza stampa del Photofestival.
C’era, pur nella inevitabile sintesi, il senso di un’attività che il grande fotografo non ha considerato come un lavoro ma come una passione vissuta in prima persona e trasmessa a tutti coloro che incontrava e che ora sono rimasti, come noi, attoniti di fronte alla sua inaspettata e prematura scomparsa.
Giovanni Gastel non aveva frequentato scuole di fotografia ma il gusto per la bellezza, l’armonia e la precisione lo aveva respirato in casa fin da piccolo avendo come riferimento non unico ma impareggiabile lo zio Luchino Visconti. Poi la strada l’aveva percorsa da solo, senza aiuti o “spinte” familiari (il padre le aveva escluse regalandogli sarcasticamente un pettinino per preparare i clienti delle fototessere) ma con un briciolo di sfrontatezza e un po’ di fortuna. Nel mondo della moda era entrato dalla porta principale: mentre era in attesa di entrare nello studio di Flavio Lucchini per mostrargli le sue fotografie lo aveva sentito urlare a Oliviero Toscani, cacciandolo, che lo avrebbe sostituito con il primo scemo che gli si fosse presentato. E la parola non era scemo. “Quello str… ero io” diceva divertito quando raccontava i suoi esordi perché agli aneddoti era affezionato.
Per quanto nel campo della moda abbia lasciato, fra campagne e servizi, tracce indelebili, non sarebbe giusto costringerlo in quella sola dimensione perché la fotografia l’ha vissuta in tutte le sue sfumature sempre guidato da un entusiasmo caratterizzato in egual misura dalla leggerezza e dalla determinazione.
Ai ritratti, smentendo le perplessità paterne, avrebbe ben presto conferito quello strano guizzo che li rendeva subito riconoscibili. Apparentemente potevano sembrare ripetitivi e invece erano ogni volta diversi: è il caso delle donne – non importa che fossero modelle, attrici, cantanti affermate che sempre definiva con aggettivi affettuosi o giovani colleghe non necessariamente famose – faceva indossare una maglia nera per concentrarsi sul volto e valorizzarlo rendendolo “gasteliano”. Siamo stati spettatori di qualcuna di queste sedute e bisognava vedere con che eleganza le rassicurava, con che meticolosità curava i dettagli, con che leggerezza scattava. Bastava vederli tutti assieme quei ritratti esposti al MAXXI di Roma in quella che sarebbe diventata la sua ultima mostra per capire come era entrato nella personalità di chi aveva ripreso.
Per anni, prima di passare più recentemente al digitale, aveva lavorato con un banco ottico Deardorf e pellicole Polaroid di grande formato ed è con quelle che aveva realizzato nel 1995 una grande personale curata da Germano Celant alla Triennale cui si accedeva calpestando un pavimento in cui le immagini erano riprodotte, un pavimento che aveva recuperato e trasferito nel suo studio di via Tortona. Uno studio bello, arioso dove un imponente archivio custodiva in grandi album tutte le sue fotografie e dove si poteva essere invitati ad assistere al suo lavoro perché Giovanni Gastel non aveva segreti neppure a riguardo della sua vena melanconica che emergeva nelle sue poesie e di cui qua e là restavano tracce come in “Maschere e spettri”, la mostra del 2009 a Palazzo della Ragione di Milano dove aveva ritratto modelle esangui ed emaciate.
Alla classicità aggiungeva un tocco innovativo soprattutto nell’uso del colore con una varietà cromatica che passava dalla delicatezza dei viraggi alla forza dirompente dei rossi e dei blu. Gli piaceva trovare soluzioni estrose da inserire nelle campagne di moda come quando fotografò una modella sul suo cavallo (con gli inevitabili e divertenti trambusti in studio) o quando ne vestì un’altra da domatrice e le mise davanti non una tigre o un leone ma un maiale. Inevitabili le sciocche polemiche di alcuni animalisti che non avevano ben osservato l’immagine e non si erano accorti che la bestiola era di cartapesta.
Nello still life era semplicemente geniale: prendeva un oggetto e lo animava in modo inaspettato con una dichiarata vena surrealista: una maschera da sub, uno snorkel e una pinna diventavano un volto, dal tacco di una scarpa da donna usciva il colore come da un tubetto da pittore, un gioiello appoggiato su una fotografia in corrispondenza di un volto e rifotografato creava creature femminili immaginifiche, fate misteriose, donne alate, fanciulle o forse angeli.
Diceva, e non scherzava, che in ognuna delle sue fotografie c’era un piccolo errore. Era in fondo il suo segreto: agiva come i compositori di ikebana che, quando pensano di aver raggiunto la perfezione, spostano un particolare per allontanarsene. Per questo le fotografie di Giovanni Gastel sapevano, sanno e sapranno conquistare.
Roberto Mutti